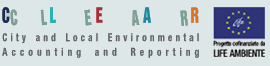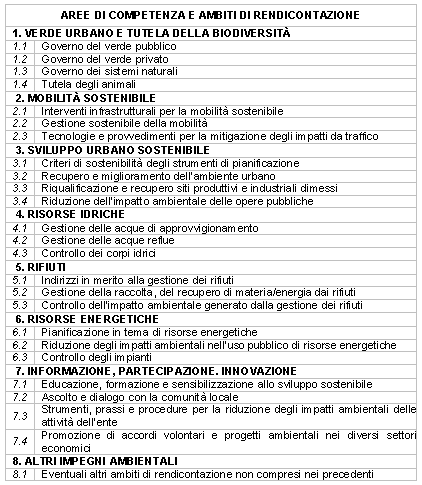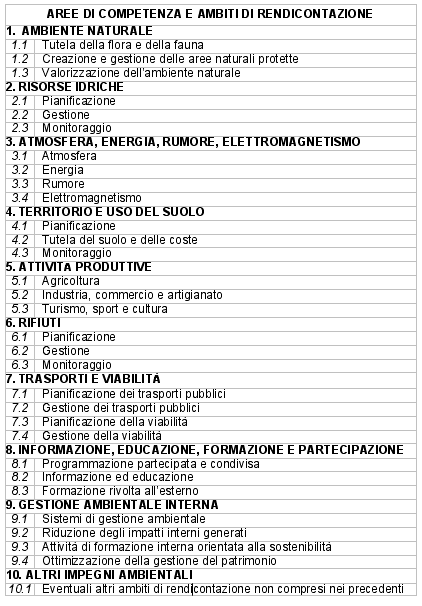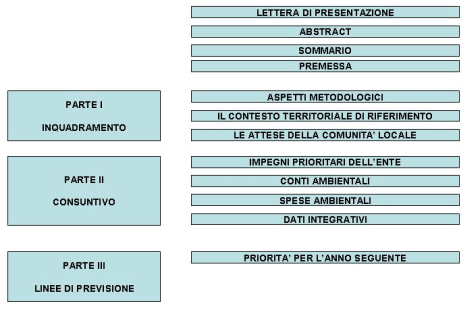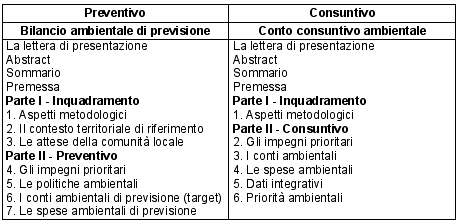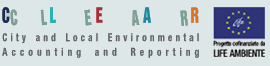 |
|
|
Stato dei lavori
Luglio 2003
È IN ARRIVO IL MANUALE OPERATIVO
Passo dopo passo, spiega come realizzare il Bilancio ambientale di un
Comune o di una Provincia secondo il Metodo CLEAR -Life
di Ilaria Di Bella
|
Il progetto CLEAR-Life è giunto al termine con successo.
I 18 enti locali partner hanno infatti approvato ciascuno il proprio Bilancio
ambientale, che contiene un consuntivo dell’anno scorso (e in qualche
caso del 2001), più linee di preventivo per il 2003, in modo da poter
essere affiancato al bilancio tradizionale, quello economico-finanziario. L’ecobilancio
ha seguito infatti lo stesso iter istituzionale degli altri documenti di programmazione
economica e finanziaria: è stato esaminato e licenziato dalla Giunta,
quindi la proposta è stata sottoposta alle commissioni competenti (per
lo più ambiente e bilancio), e infine è arrivata la discussione
e il varo definitivo da parte del consiglio comunale o provinciale.
È la prima volta in Europa che un gruppo così esteso di amministrazioni
locali approva un Bilancio ambientale, per di più costruito grazie a
quasi 2 anni di sperimentazione svolta in modo coordinato, con le stesse procedure
utilizzate per il bilancio economico-finanziario.
A giugno il comitato guida, composto dai rappresentanti politici e amministrativi
di tutti i partner, ha dato il via libera al manuale operativo (Metodo CLEAR:
dalla contabilità alla politica ambientale): le linee guida per realizzare,
sulla scorta dell’esperimento appena condotto a termine, un bilancio “verde”
secondo il metodo sperimentato, che ha la peculiarità di privilegiare
un’ottica per così dire “politica”, ovvero di realizzare
uno strumento utile agli amministratori comunali e provinciali sia per stabilire
priorità di intervento che per valutare l’efficacia e l’efficienza
di azioni, interventi, piani, programmi in tutti i settori che implicano ricadute
sull’ambiente.
Il manuale operativo
Metodo CLEAR è il volume che raccoglie tutti gli elementi che vanno a
comporre il manuale operativo. Alcuni contributi di autori diversi introducono
la filosofia sottesa alla sperimentazione; il corpo centrale del volume descrive
il metodo seguito, traccia un modello di riferimento e dà indicazioni
circa i principali problemi da affrontare e alcune soluzioni sia teoriche che
pratiche; gli allegati contengono esempi, tabelle e schemi di rendicontazione
che può essere utile usare per costruire il bilancio.
Il volume sarà disponibile a settembre insieme a un cd (Il Progetto CLEAR:
strumenti, metodi, risultati) contenente anche gli strumenti metodologici, i
bilanci approvati da tutti gli enti, nonché articoli di commento e valutazione
dei risultati.
La filosofia di riferimento
Alla base del processo proposto c’è il passaggio dal “contare,
al contabilizzare, al rendicontare”, un modello che in inglese può
essere reso dai due termini di “accounting” (ovvero “contabilità”,
ma anche “fare i conti”) e “accountability” (ovvero
“render conto”, o anche “assumersi la responsabilità
di ciò che si dichiara”), in cui il secondo termine indica una
tappa successiva rispetto al primo.
La fase del “contare” è quella del monitoraggio e della raccolta
di dati sullo stato dell’ambiente e sulle principali dinamiche tra l’economia
(e quindi l’uomo e le sue attività) e gli ecosistemi naturali.
Può essere completamente scollegata dalle decisioni politiche, anche
se è certamente un punto di partenza fondamentale.
Nella successiva fase del “contabilizzare”, i dati, le informazioni,
le conoscenze sull’ambiente e sulle interazioni con le attività
umane vengono messi a sistema, in modo da poter stabilire dei rapporti se non
di causa ed effetto, almeno di correlazione o di influenza, tra i fenomeni economici
e sociali e le varie forme di inquinamento. Nasce così il Rapporto sullo
Stato dell'Ambiente, una sorta di eco-fotografia di un determinato territorio,
che consente di cominciare a delineare trend ed esiti dei fenomeni ambientali.
“Contando” e “contabilizzando” è possibile insomma
“amministrare ciò che si misura”, ovvero gestire le informazioni
sull’ambiente, altrimenti destinate a divenire un “cimitero di dati”,
perché siano utili. È questo ciò che gli anglosassoni chiamano
“accounting”: siamo già nel campo della contabilità
ambientale, ma non ancora al suo apice, costituito dalla fase successiva, quella
del “rendicontare”, che può essere resa con il termine di
“accountability”, a dire il vero molto più ricco di implicazioni
e senza una precisa traduzione in italiano.
Rendicontare significa appunto “rendere conto”; per un’amministrazione
pubblica, guidata da organismi elettivi come un ente locale, implica l’assunzione
di responsabilità in relazione a un determinato stato dell’ambiente,
e soprattutto agli impatti, sia postivi che negativi, delle politiche economiche,
sociali, di settore, sull’ecosistema di riferimento. E siccome le politiche
attuate da un Comune o da una Provincia dipendono dalle competenze attribuite
all’ente dalla legge e dallo stato di salute del territorio, ma anche
dalle priorità stabilite dal programma dell’amministrazione, e
quindi dalle decisioni prese dalle giunte e dai consigli, l’adozione di
un bilancio “verde” (secondo la filosofia del rendicontare) si traduce
nel garantire ai cittadini più trasparenza, più democrazia, e
quindi buona governance. In poche parole, significa “misurare ciò
che l’ente amministra”.
Al percorso descritto corrisponde anche un’evoluzione storica degli strumenti
di gestione dell’ambiente. Dal semplice monitoraggio e dalla raccolta
di dati “grezzi” degli anni Ottanta, in cui sono nati in Italia
gli assessorati dedicati all’ambiente e lo stesso ministero, si è
passati negli anni Novanta ai Rapporti sullo Stato dell’Ambiente, per
approdare all’adozione di strumenti più sofisticati come i sistemi
di gestione ambientale, l’Agenda 21, la contabilità ambientale
e, infine, l’ecobilancio.
La definizione della struttura
di rendicontazione
La prima domanda da porsi quando ci si accinge a redigere un Bilancio ambientale
di un’amministrazione locale è: su che cosa rendicontare?
Il quesito può apparire banale, ma non lo è, dal momento che siamo
abituati a considerare “ambientali” solo le politiche che afferiscono
direttamente all’assessorato all’ambiente, cioè aree verdi
e parchi, interventi di risanamento di aree inquinate, in qualche caso la difesa
del suolo, l’informazione e la formazione in materia di sviluppo sostenibile
e poco altro. In realtà i settori che hanno più conseguenze sia
dirette che indirette sull’ambiente sono le attività produttive,
i lavori pubblici, l’urbanistica, l’energia, i trasporti.
La più grande sfida del progetto è stata di provare ad assumere
un’ottica “intersettoriale”, “trasversale” dell’ambiente,
di tentare una valutazione degli impatti sull’ecosistema territoriale
delle principali politiche settoriali e non solo di quelle più tipicamente
definite ambientali. Il primo nodo da sciogliere è stato dunque definire
gli “ambiti” del Bilancio ambientale, ovvero i confini dell’attività
di rendicontazione.
Quelle che poi sono state denominate “aree di competenza” sono state
ottenute incrociando i criteri di sostenibilità della Valutazione Ambientale
Strategica utilizzata dall’Unione europea per valutare progetti, piani
e programmi, con le competenze attribuite al Comune e alla Provincia dalla legge.
Ogni area di competenza è stata poi suddivisa in più dettagliati
ambiti di rendicontazione. Per i Comuni sono state definite 8 aree di competenza,
per le Province 10.
Tabella 1 / La struttura di rendicontazione per un Comune
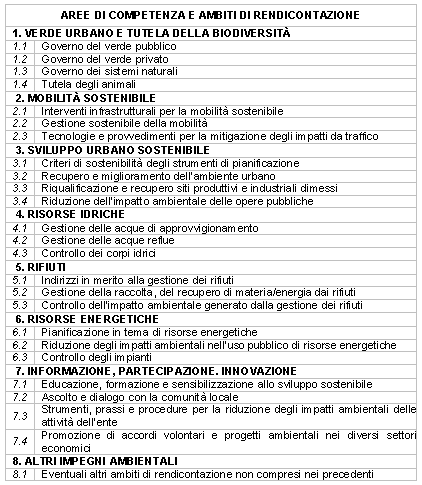
Tabella 2/ La struttura di
rendicontazione per una Provincia
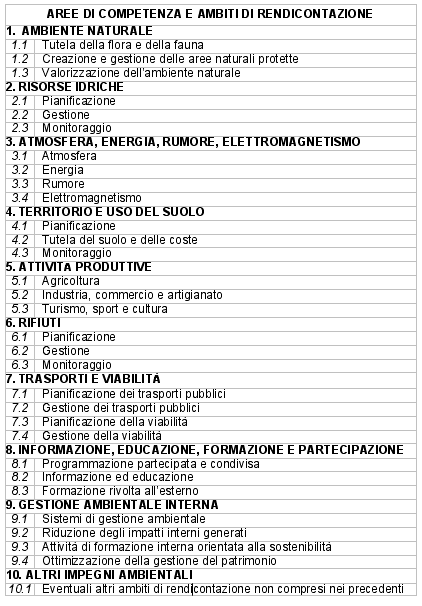
Come si può vedere dalle due tabelle riportate, sono stati considerati
settori soggetti a ricadute ambientali quelli dei trasporti, dell’energia,
dell’urbanistica, oltre a quelli più classici relativi alla gestione
dei rifiuti, delle risorse idriche e delle aree verdi. È chiaro che si
tratta di una classificazione convenzionale, pattuita tra i partner, che in
futuro potrà essere ulteriormente estesa per comprendere, per esempio,
il settore delle politiche sociali.
La definizione delle politiche
Ma qual è procedura che può essere ripetuta da un Comune o da
una Provincia che vuole realizzare il Bilancio ambientale?
La lente di ingrandimento attraverso cui, secondo la filosofia del progetto,
è stato filtrato l’approccio alle dinamiche dell’amministrazione
è stata quelle delle politiche. Si è detto: per poter decidere,
agire, gli amministratori (sindaci, presidenti di Provincia, assessori, consiglieri
comunali e provinciali) hanno bisogno di una “cassetta degli attrezzi”,
ovvero di strumenti per capire cosa succede all’ambiente e alle risorse
naturali, quale impatto hanno le politiche, cosa si può fare con i budget
finanziari a disposizione, quali sono gli investimenti “verdi” più
produttivi.
Per prima cosa è necessario, quindi, definire le ricadute ambientali
delle principali politiche attuate dagli enti locali. Ciascun Comune e ciascuna
Provincia devono fare un elenco delle politiche, suddivise in indirizzi, obiettivi,
attività e riclassificare questa mole di informazioni (proveniente dall’analisi
documentale di programmi politici, relazioni, piani e bilanci) secondo la struttura
di rendicontazione adottata, che aiuta ad esplicitare gli aspetti ambientali
di ciascun intervento. Si tratta di “rendere esplicite” le politiche
per l’ambiente e quindi di far emergere anche il loro ordine di priorità,
ovviamente frutto degli intendimenti della giunta. Protagonisti del lavoro,
oltre ai dirigenti e agli staff costituiti per la sperimentazione, sono gli
assessori e i loro dirigenti, e non solo quelli all’Ambiente, ma anche
quelli al Bilancio, ai Trasporti, all’Urbanistica, ai Lavori Pubblici.
Il prodotto finale è un elenco dettagliato, che costituisce un output
a sé stante del sistema di contabilità ambientale, perché
ricco di informazioni sulle strategie politiche per l’ambiente attuate,
o in programma, per il territorio. Il manuale raccomanda di coinvolgere, in
questa fase, in modo diretto gli assessori, e non solo la macchina amministrativa,
che pure è fondamentale per raggiungere un buon risultato.
Box / La differenza
tra indirizzi, obiettivi, attività
Gli indirizzi sono gli impegni strategici di lungo periodo
che vanno oltre il mandato dell’amministrazione e che sono realizzati
attraverso un insieme coordinato di obiettivi di medio-breve periodo.
Gli obiettivi sono gli impegni strategici di medio o breve
periodo contenuti nel programma di mandato, nella relazione revisionale
e programmatica o che sono indicati dagli amministratori.
Le attività sono le principali azioni realizzate
o che si intende realizzare nel breve periodo per perseguire le politiche
ambientali dell’ente. |
La definizione del sistema contabile
Dopo aver “dichiarato” gli aspetti ambientali delle politiche, è
necessario costruire un piano dei conti, che significa scegliere gli indicatori
fisici da abbinare alle corrispondenti voci inserite nella struttura contabile,
ovvero agli indirizzi, agli obiettivi e alle attività.
Il presupposto di partenza del progetto era quello di non creare nuovi set di
indicatori, ma semmai di distinguere, tra quelli già in uso presso gli
enti partner (per il Rapporto Stato Ambiente, per l’Agenda 21) i più
utili allo scopo di monitorare le politiche e di valutarne l’efficacia
e l’efficienza.
A tal fine i 18 enti partner che hanno preso parte al progetto proprio erano
già all’avanguardia nell’adozione di sistemi di monitoraggio
del territorio. Sono tutti membri del Coordinamento italiano dell’Agenda
21 e pubblicano regolarmente un Rapporto sullo Stato dell’Ambiente; alcuni
sono certificati EMAS o ISO 14001, altri avevano sperimentato prime forme di
ecobilancio.
Ogni Comune e ciascuna Provincia aveva quindi, già in partenza, a disposizione
i dati relativi a diverse centinaia di indicatori fisici, magari anche in serie
storica, riguardanti, solo per fare alcuni esempi, qualità dell’aria
e dell’acqua, consumi idrici e di energia, produzione di rifiuti e di
inquinanti del territorio di riferimento. Si trattava dunque di fare ordine
nella gran quantità di dati, e soprattutto di mettere in relazione le
informazioni con le azioni dell’amministrazione, per poter fare previsioni
e programmi, e in seguito valutarne gli effetti.
La procedura seguita nel corso della sperimentazione, e proposta dal manuale,
consiste nella scelta, tra gli indicatori fisici in base ai quali un ente già
raccoglie informazioni, quelli più semplici e facilmente rilevabili,
più strettamente correlati alle competenze, alle politiche e agli obiettivi
dell’ente e soprattutto significativi per amministratori e stakeholder
(portatori di interessi).
Il gruppo dei partner ritiene inoltre auspicabile, nel tempo, l’adozione
del set dei 10 indicatori + 1 del programma ECI (European Common Indicators)
della Commissione europea, pensato per l’ambito urbano e come tale direttamente
trasferibile ai comuni, da adattare con modifiche invece all’ambito provinciale.
Il piano dei conti costituisce il sistema contabile dell’ente, che va
gestito in modo informatizzato, per sapere con certezza ogni anno dove reperire
i dati e come elaborarli.
Box / La definizione
di spesa ambientale concordata dai partner CLEAR
| “Sono da considerare come ambientali le spese sostenute per attività
di prevenzione, riduzione, eliminazione e monitoraggio dell’inquinamento,
ripristino e gestione sostenibile del territorio” |
La riclassficazione viene effettuata sulla base dei dati presenti nella contabilità
finanziaria (quella economica, se pure più aderente alle esigenze informative
dell’ecobilancio non è sufficientemente diffusa negli enti locali),
i documenti da analizzare sono soprattutto il Conto consuntivo, il Bilancio
di previsione e il Piano Esecutivo di Gestione.
Le spese per le quali è stato accertato un contenuto ambientale vengono
poi rilcassificate in base alle aree di competenza della struttura di rendicontazione
(vedi tabelle 1 e 2). È possibile, in modo più dettagliato, riferire
le voci di spesa anche agli ambiti di rendicontazione.
È chiaro che gli “importi stanziati” dall’ente rendono
conto delle politiche definite (ovvero delle priorità stabilite), gli
“impegni di spesa” rendono conto dello stato di avanzamento relativo
all’attuazione delle politiche, mentre gli “importi liquidati”
dall’ente rendono conto della effettiva realizzazione degli interventi.
È consigliato coinvolgere nelle operazioni che riguardano i conti monetari
anche i responsabili della Ragioneria.
Un capitolo a parte riguarda le aziende dei servizi pubblici locali che gestiscono
il rifornimento idrico, lo smaltimento dei rifiuti e i trasporti urbani. Per
avere un quadro più realistico della spesa ambientale comunale o provinciale
è necessario inserire nel Bilancio ambientale dell’ente anche un
quadro dei bilanci di queste società.
Il reporting
Il manuale operativo dedica un intero capitolo alla fase di reporting, che è
anche quella più importante ai fini della redazione del Bilancio ambientale
e dell’aderenza ai principi cui esso si ispira (più trasparenza,
più responsabilità, miglioramento della governance). Al momento
della rendicontazione vera e propria è necessario che siano coinvolti
tutti i protagonisti che hanno partecipato alla costruzione del sistema contabile,
e in particolare gli assessori, che di fatto rendicontano sulla loro attività
passata (Bilancio ambientale consuntivo) oppure futura (Bilancio ambientale
preventivo). È dunque una fase di assunzione diretta della responsabilità,
che predispone alla discussione del documento finale nella giunta, nelle commissioni
e nel consiglio. Tutti i partner hanno utilizzato lo stesso schema di rendicontazione.
Box / I contenuti del Bilancio ambientale
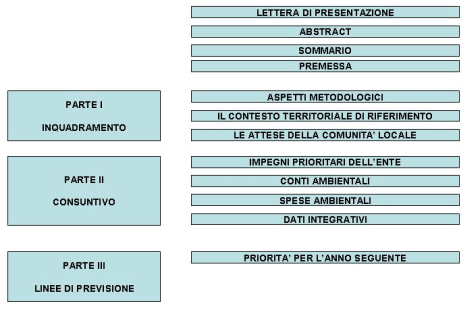
Il sistema di governance
La finalità ultima del progetto è di migliorare la governance
locale, ovvero l’insieme delle regole di controllo e di guida che caratterizzano
l’amministrazione dei comuni e delle province. Il Bilancio ambientale
aumenta la trasparenza e favorisce l’assunzione di responsabilità
da parte degli attori sociali. Per fare questo deve seguire lo stesso iter istituzionale
del bilancio economico-finanziario e dei principali documenti di programmazione,
perché ciò garantisce il confronto democratico sui suoi contenuti,
nonché l’emersione delle problematiche ambientali dalla nicchia
di settore e la loro proficua correlazione con i fenomeni economici e sociali.
Il percorso si conclude con l’approvazione da parte del consiglio comunale
o provinciale, possibilmente in parallelo con gli altri documenti economici,
anche se è preferibile non presentarlo come un allegato del bilancio
finanzio per evitare un calo di interesse.
Altro capitolo fondamentale è l’integrazione, necessaria, tra il
bilancio “verde” e gli altri strumenti ordinari dell’ente
(come il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Regolatore, i contratti di servizio
con le aziende dei servizi pubblici locali, la Relazione previsionale e programmatica).
La struttura del piano dei conti e il sistema contabile devono essere oggetto
di confronto con i gruppi portatori di interessi presenti sul territorio (stakeholder:
associazioni di vario genere e di categoria, scuole, sindacati, parrocchie,
comunità di immigrati ecc), anche per incrementare la diffusione di responsabilità.
Tra le priorità dell’ente è possibile inserire un capitolo
specifico relativo ai target, obiettivi di medio periodo che in termini percentuali
o assoluti quantificano gli impegni dell’ente per la riduzione del consumo
di risorse naturali, la produzione di sostanze inquinanti, e in relazione ad
altri livelli di prestazione ambientale. Si tratta dell’applicazione di
un altro progetto Life, Ecobudget dell’ICLEI, il cui output può
essere integrato con profitto al Bilancio ambientale targato CLEAR-Life.
Il Bilancio ambientale a regime
Nella fase di avvio del processo di contabilità ambientale l’ecobilancio
viene, di norma, approvato una sola volta all’anno, in corrispondenza
con il bilancio preventivo. A regime tuttavia, l’ecobilancio segue lo
stesso iter del bilancio tradizionale, e vengono quindi approvati due documenti
separati: un consuntivo per l’anno precedente più un preventivo
per l’anno successivo.
Box / La struttura del Bilancio ambientale a regime
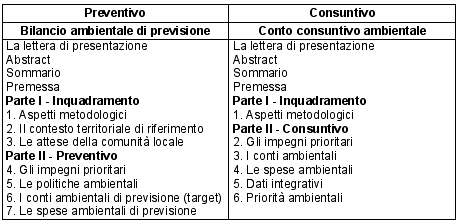
Le questioni aperte
Quella che si sta concludendo è solo una fase sperimentale di adozione
dell’ecobilancio. È chiaro dunque che il metodo e le procedure
seguite per la sua realizzazione presentano margini di miglioramento.
Il nodo più spinoso è quello del rapporto tra le reali competenze
dell’ente e la risoluzione dei problemi ambientali, per loro natura globali.
In questi casi (per esempio per quanto riguarda i cambiamenti climatici) il
bilancio “verde” è utile soprattutto per promuovere la consapevolezza
e l’assunzione di responsabilità diffusa in relazione a fenomeni
planetari.
Ma altre questioni rimangono aperte, in attesa del proseguimento dell’esperienza.
Innanzitutto è necessario promuovere una maggiore integrazione con gli
altri strumenti di sostenibilità e di gestione del territorio adottati
dall’ente, in secondo luogo occorre prendere in considerazione l’attività
delle aziende dei servizi pubblici locali, e prevedere un’integrazione
con i loro bilanci.