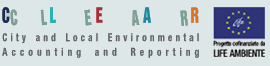
I disegni di legge sulla contabilità ambientale
al Senato
Presto una legge?
di Ilaria Di Bella
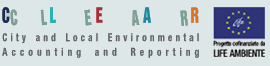 |
|
|
|
La contabilità ambientale torna all’ordine del
giorno del Senato. Tre i disegni di legge attualmente all’esame della
commissione Ambiente. Alla proposta di legge Giovanelli, ripresentata nel testo
già licenziato da Palazzo Madama nella passata legislatura, sono stati
affiancati analoghi disegni di legge dei Verdi e di Alleanza nazionale. Il relatore
(che ha il compito di illustrare le proposte alla commissione, e poi all’Aula,
seguendo l’intero esame del provvedimento) è il senatore Egidio
Luigi Ponzo (Forza Italia). Un “comitato ristretto”, composto da
un senatore per gruppo parlamentare più il relatore, è stato incaricato
di effettuare audizioni tra i soggetti interessati e di arrivare a un “testo
unificato”, sulla base del quale presentare emendamenti.
Un po’ di storia
Primo: far emergere nelle politiche pubbliche i “costi occulti”
dello sviluppo, pagati in termini di esaurimento delle risorse naturali non
rinnovabili e di impoverimento di quelle rinnovabili, di misure contro l’inquinamento,
di spese per il risarcimento del danno dopo le calamità o per le cure
mediche dovute alle condizioni insalubri di vita. Tutti costi “a carico
dell’ambiente”, non computati dalla contabilità tradizionale,
che considera ancora un’alluvione come un aumento del Prodotto Interno
Lordo.
Secondo: fornire agli amministratori pubblici uno strumento per tenere conto
della realtà di questi costi ambientali nel valutare l’efficacia
e l’efficienza delle politiche di governo del territorio, e in particolare
delle città dove vive la maggioranza della popolazione italiana.
Con questi obiettivi nel 1998 nasce in Italia il primo disegno di legge sulla
contabilità ambientale pubblica, finalizzato a istituire l’obbligo,
per Comuni, Province, Regioni e Stato, di adottare un bilancio ambientale accanto
a quello tradizionale di natura economico-finanziaria. Il primo firmatario del
disegno di legge, unico nel suo genere e senza omologhi in Europa, è
il diessino Fausto Giovanelli, allora presidente della Commissione Ambiente
del Senato. La proposta è il frutto della lunga collaborazione tra Palazzo
Madama e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), che
raccoglie indicazioni e osservazioni da parte dei principali soggetti interessati,
dall’Istat al ministero dell’Ambiente, dalla Ragioneria generale
dello Stato all’Anpa e alle Arpa, dall’Enea all’Anci, dall’Upi
alle Regioni.
Il testo finale viene sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari (eccetto la
Lega) e approvato dal Senato il 14 luglio 1999. La Camera non riuscirà
a terminarne l’esame prima della fine della legislatura (marzo 2001).
Nel frattempo, alcuni enti locali decidono che è venuto il momento di
sperimentare questa nuova forma di contabilità proposta dal disegno di
legge. La Provincia di Bologna dà il via, con un finanziamento del ministero
dell’Ambiente, a un progetto che produrrà uno studio sul costo
reale dell’acqua corrente (molto più alto di quello effettivamente
pagato dai cittadini).
Nasce il progetto CLEAR, finanziato dalla Commissione Europea: ben 18 enti locali
approveranno, entro la prima metà del 2003, il proprio “ecobilancio”,
seguendo un percorso di ricerca coordinato che approderà alla realizzazione
di un metodo e di principi contabili.
La struttura del disegno di legge
Due sono le scelte di fondo operate dal disegno di legge.
La prima riguarda l’adozione della contabilità ambientale come
strumento per orientare alla sostenibilità le politiche economiche. La
tesi è che solo “internalizzando” i costi occulti di natura
ambientale, ovvero facendo in modo – attraverso la politica e l’amministrazione
– che il mercato tenga conto del “prezzo” dell’ambiente,
il perseguimento dello sviluppo sostenibile non sarà un ossimoro ma una
realtà.
La seconda è che quello ecologico sia un bilancio satellite rispetto
al bilancio economico-finanziario, rinunciando così, per ora, a ogni
irrealistica ipotesi di integrazione tra le due contabilità o di correzione
in senso ambientale dei documenti di bilancio tradizionali (tendenza che aveva
portato a teorizzare, ad esempio, il “PIL verde”). I presupposti
sono il V Programma d’azione ambientale della Comunità Europea,
che raccomanda l’adozione di conti ambientali satellite da parte degli
stati membri, e le azioni dell’UE finalizzate all’individuazione
di un set comune di indicatori ambientali per monitorare lo stato dell’ambiente
e l’efficacia delle politiche.
In questo caso la tesi è che in campo ambientale è necessario
passare dal “laboratorio alle istituzioni”, che significa smettere
di ricercare indicatori e altri strumenti statistici perfetti e realizzare invece
una “cassetta degli attrezzi” in grado di aiutare da subito gli
amministratori pubblici. Per questo il target di riferimento è costituito
dagli organi di governo della Pubblica amministrazione e non dalle imprese,
che hanno già adottato volontariamente bilanci e altri strumenti per
la gestione ambientale.
Il disegno di legge istituisce l’obbligo per i Comuni, le Province, le
Regioni e lo Stato di approvare, entro il 2004, bilanci “verdi”
accanto e “contestualmente” (cioè nello stesso momento) ai
tradizionali documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.
I due documenti vengono così “appaiati” e confrontati, dagli
organi di governo del territorio, nella stessa sessione di bilancio. La scadenza
viene differita al 2007 per i Comuni più piccoli.
Entro il 2003 gli enti locali e lo Stato dovranno invece dotarsi di sistemi
di conti ambientali, cioè di sistemi informativi che misurano la consistenza
e le variazioni del patrimonio naturale, le interazioni tra l’economia
e l’ambiente, le spese per la prevenzione, la protezione e il ripristino
in materia ambientale. Si tratta in sostanza dei dati sui cui vengono poi costruiti
gli “ecobilanci”.
Gli strumenti statistici e tecnico-scientifici indicati dal disegno di legge
per l’elaborazione dei dati ambientali sono quelli messi a punto dall’Istituto
di statistica europeo (Eurostat) e da quelli dei Paesi membri. Si tratta in
particolare del SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l’Information
Economique sur l’Environnement), un sistema di conti satellite studiato
per affiancare le informazioni fornite dai conti economici ad altre sulla spesa
per la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento,
del NAMEA, una matrice che affianca informazioni fisiche e monetarie, e del
sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale, che consente di
misurare in termini fisici la pressione esercitata sull’ambiente dalle
attività umane.
Per quanto riguarda le competenze, la gestione del sistema dei conti viene affidata
all’Istat, mentre l’Enea contribuisce a elaborare strumenti e modelli;
la raccolta dei dati alle Regioni, alle Province e ai Comuni, insieme all’Anpa
e alle Arpa.
Prevista anche una fase di sperimentazione finanziata, che precede qualsiasi
termine perentorio.
Altre proposte sul tavolo
Le altre proposte sul tavolo della Commissione Ambiente hanno la stessa struttura
del disegno di legge Giovanelli, con qualche differenza.
Il testo di cui è primo firmatario il senatore Giuseppe Specchia (An)
contiene un unico termine (il 2004 per i Comuni più grandi, il 2007 per
quelli più piccoli) per l’adozione dei bilanci ambientali (che
vengono definiti documenti di contabilità ambientale), strutturati sulla
base dei conti ambientali di competenza di ciascun livello istituzionale (senza
prevedere una scadenza per l’introduzione obbligatoria di questi ultimi).
Vengono specificate nel dettaglio le competenze spettanti allo Stato, alle Regioni
e agli enti locali in materia di contabilità ambientale. Allo Stato spettano
compiti di indirizzo, controllo e supporto, nonché di revisione della
contabilità economica nazionale, e l’applicazione delle metodologie
al bilancio. Le Regioni dovranno fornire indicazioni agli enti locali e adeguare
i propri strumenti contabili, mentre agli enti locali spetterà il compito
di fornire informazioni agli enti sovraordinati (oltre a redigere propri ecobilanci).
Tra gli organismi istituzionali coinvolti, viene inserito anche il CNR, che
provvede a eseguire rilevamenti ambientali utilizzando le tecnologie installate
sul Laboratorio aereo per la ricerca ambientale.
Il provvedimento del Sole che ride, di cui è primo firmatario il senatore
Sauro Turroni, vicepresidente della Commissione Ambiente, prevede un unico termine,
il 2004, per l’entrata in vigore dell’obbligo relativo all’adozione
del “documento di contabilità ambientale” per i Comuni, le
Province, le Regioni e lo Stato. Accanto alla contabilità ambientale
pubblica, viene inquadrata anche quella del settore privato. Le imprese che
si dotano di ecobilanci vengono iscritte in un albo e si avvalgono di un credito
d’imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute per la sua predisposizione.
Nelle misure di sviluppo sostenibile viene inserito anche il “bilancio
ecologico territoriale”, che quantifica i livelli di emissioni inquinanti
globali del territorio di competenza degli enti locali e delle Regioni e rappresenta
la base per la creazione dei patti territoriali per lo sviluppo sostenibile,
fornendo un criterio di priorità assoluta per i finanziamenti.
| Dalla delegazione interparlamentare una risoluzione sulla contabilità verde pubblica e privata |
|
Perseguire lo sviluppo sostenibile attraverso un approccio integrato, che coinvolga tutte le iniziative e i poteri pubblici. Considerare la sostenibilità una volta per tutte come un giano bifronte, con una dimensione ambientale e l’altra, inseparabile, sociale. Riformare la governance a tutti i livelli, anche attraverso la contabilità “verde”. Sono questi i temi della risoluzione approvata al World Summit di Johannesburg dalla delegazione “interparlamentare”, composta da senatori e deputati di tutti i parlamenti del mondo. Approvato al termine di una settimana di incontri, il documento investe le assemblee legislative del mondo della responsabilità di riformare la governance e i processi decisionali per “tenere conto degli imperativi dello sviluppo sostenibile”. Per attuare un approccio integrato allo sviluppo sostenibile in tutte le iniziative e nelle istituzioni pubbliche, i parlamentari si sono impegnati a lavorare a nuove norme di regolazione e amministrazione e a mettere a punto agende nazionali per la sostenibilità sulla base di obiettivi quantificati. I rappresentanti delle assemblee elettive hanno inoltre convenuto sulla necessità di introdurre regole più severe in materia di studi di impatto ambientale e leggi in materia di contabilità ambientale sia nel settore pubblico che in quello privato. Le istituzioni e i processi democratici dovranno inoltre essere “conformi allo stato di diritto e rispettosi dei diritti fondamentali dell’uomo”. |
|---|
Documenti correlati:
-Disegno di Legge n. 188 Fausto Giovanelli
-Disegno di Legge n. 958 Giuseppe Specchia
-Disegno di Legge n. 900 Sauro Turroni