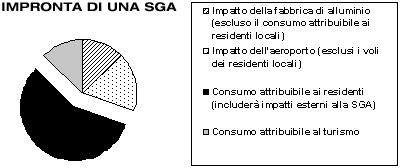
L’impronta ecologica e l’analisi
della biocapacità
come indicatori di sostenibilità
per le Aree Geografiche Sub – nazionali:
raccomandazioni
Rapporto Finale 27 Agosto 2001
Include anche i risultati del Workshop di Oslo del 24-26 Agosto 2001
|
Definizioni |
Definizioni
Nelle pagine che seguono si farà uso della seguente terminologia e delle
seguenti abbreviazioni:
IdN –Studio e Metodologia de “L’Impronta delle Nazioni”,
utilizzati per il calcolo di impronte e biocapacità di 52 Nazioni secondo
le indicazioni di Wackernagel et al (1999) e Chambers, Simmons e Wackernagel
(2000). Tali studi si riferiscono a dati sui consumi del 1993. Il foglio di
calcolo si può scaricare dal sito www.rprogress.org.
LPR – La metodologia aggiornata utilizzata per il calcolo delle impronte
e delle biocapacità di 152 Nazioni per il “Living Planet Report
2000’ pubblicato dal WWF International.
I calcoli sono stati eseguiti su dati del 1996 da Mathis Wackernagel et al.
Il foglio di calcolo completo si può scaricare dal sito www.rprogress.org.
Il WWF si è impegnato ad aggiornare il rapporto con periodicità
biennale. La prossima edizione sarà pubblicata in tempo per il Congresso
Mondiale per lo Sviluppo Sostenibile del 2002 (Rio + 10).
AGS – Area geografica sub – nazionale. Qualsiasi area geografica ben
definita, più piccola dello Stato, ad esempio una regione, un comune,
un bacino idrografico o una città. Questo termine è stato introdotto
allo scopo di risolvere il problema della definizione dell’area di investigazione
(che cosa costituisce una città?) e le differenze fra strutture politiche
ed amministrative dei diversi Stati Nazione Europei.
I concetti di Impronta Ecologica e Biocapacità
L’impronta ecologica (EF) misura
la quantità di area bioproduttiva (sia essa terra o acqua) di cui una
popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che
consuma e per assorbire i rifiuti che genera con la tecnologia prevalente. L’impronta
indica pertanto la domanda di risorse.
Per via dei meccanismi di mercato, queste aree possono essere ubicate ovunque
sul pianeta e l’impronta è un aggregato di vari appezzamenti di
diversa misura e tipologia, situati in aree climatiche diverse.
La biocapacità (BC) misura l’offerta
di bioproduttività, ossia la produzione biologica di una data area. Essa
è data dalla produzione aggregata dei diversi ecosistemi appartenenti
all’area designata, che vanno dalle terre arabili ai pascoli alle foreste
alle aree marine produttive e comprende, in parte, aree edificate o in degrado.
La Biocapacità non dipende dalle sole condizioni naturali, ma anche dalle
pratiche agricole e forestali dominanti.
Impronta ecologica e biocapacità sono di norma introdotte congiuntamente.
Nell’IdN e nel LPR vengono espresse in termini delle medesime unità
di misura: ettari di spazio bioproduttivo medio mondiale. Un’aggregazione
significativa di aree di qualità eterogenea è possibile solo ove
si operi una tale normalizzazione.
La normalizzazione dell’impronta ecologica (ove espressa in termini di
rendimenti medi globali) si ottiene mediante dei fattori di equivalenza –
ossia dei moltiplicatori che pesano i diversi tipi di terreno e di area marina
a seconda della rispettiva bioproduttività.
Nel calcolo della biocapacità di un’area, le tipologie di terreno
e le aree marine disponibili sono normalizzate rispetto ad equivalenti medi
mondiali per mezzo di fattori di rendimento locali, che sono dei moltiplicatori
che esprimono la misura in cui la bioproduttività locale è maggiore
o minore della media mondiale per quella tipologia di terreno o area marina.
L’impronta e la biocapacità sono state
utilizzate per indicare:
1. L’entità della domanda di risorse scarse a livello globale,
nazionale, regionale, ecc. da parte dell’uomo.
2. Se il consumo medio pro capite è sostenibile ed equo rispetto alla
biocapacità globale media disponibile.
3. La possibilità per i paesi/AGS di vivere avvalendosi della sola biocapacità
che si trova all’interno dei loro confini.
Esistono inoltre numerose analisi correlate a studi sull’impronta ecologica
che comparano, ad esempio, Impronte ecologiche nazionali con l’andamento
economico (Sturm et al. 2000, Chambers et al. 2000), con indicatori di benessere
e con indici di deprivazione sociale (Lewis 1997).
Ulteriori approfondimenti
Gli autori hanno redatto due documenti di approfondimento per coloro
che fossero interessati alla comprensione dei concetti di impronta ecologica
e biocapacità:
- Ancora sull’Analisi dell’Impronta Ecologica
- Critiche all’analisi dell’impronta ecologica e della biocapacità
Entrambi i documenti sono contenuti nell’Allegato 1.
Descrizione dei criteri
Di seguito si introduce un insieme di criteri il cui scopo è quello
di evidenziare le differenze fondamentali fra le diverse applicazioni del concetto
di impronta ecologica all’interno dell’UE. L’obiettivo finale
è quello di arrivare ad un metodo comune e concertato per l’analisi.
I criteri sono poi applicati agli studi a carattere nazionale più significativi,
presentati nel corso del workshop di Roma. La tavola 1 riporta i risultati di
questa valutazione.
Criterio 1: Principio ‘Geografico’
o ‘di responsabilità”
Questione fondamentale è se lo scopo dello studio sia quello di determinare
l’impronta dell’AGS o del consumo dei suoi abitanti (la comunità).
I rispettivi risultati possono essere molto diversi: si immagini, ad esempio
una piccola area contenente un aeroporto. Dobbiamo includere nell’impronta
tutto l’impatto dell’aeroporto o stimare invece solo quella parte
dell’impatto riconducibile agli abitanti della regione? Il primo approccio
viene definito “principio geografico” mentre il secondo “principio
di responsabilità” (si veda la scheda metodologica dell’indicatore
ECIP A2).
Criterio 2: Rendimenti locali o rendimenti
globali
Valutazioni sull’opportunità di definire i rendimenti dei prodotti
agricoli e forestali in base ai rendimenti locali (ossia relativi all’AGS),
nazionali o rispetto alla media mondiale.
Gli studi si suddividono in genere fra quelli che cercano di calcolare l’impronta
in base a rendimenti effettivi (Italia), quelli che ricorrono alle medie mondiali
(Svezia, IdN, LPR) e quelli che fanno uso di entrambi i criteri (Regno Unito,
Olanda).
Se il consumo viene espresso in termini di rendimenti effettivi, i risultati
non possono essere confrontati agevolmente con altri paesi o altre aree e non
si può effettuare alcuna valutazione in termini di sostenibilità
globale. Ciò in virtù del fatto che i risultati non sono espressi
in termini di area bioproduttiva mondiale media.
Tuttavia, i rendimenti effettivi contengono informazioni utili ai fini della
pianificazione della sostenibilità a livello regionale e forniscono informazioni
più precise sull’area produttiva di cui ci si avvantaggia effettivamente,
nonché sulla sua distribuzione sul pianeta. Si riconosce peraltro l’estrema
difficoltà di ottenere informazioni circa i rendimenti locali di tutti
i prodotti importati.
Criterio 3: I fattori di equivalenza
Il criterio in oggetto evidenzia se, in sede di calcolo dell’impronta ecologica,
i diversi tipi di terreno siano pesati per la propria bioproduttività.
Ove non si faccia uso dei fattori di equivaIenza, il consumo di diversi tipi
di terreno non può essere aggregato in un’unica impronta e, inoltre,
il risultato non può essere facilmente confrontato con quelli relativi
ad altre regioni, in quanto gli ettari non sono stati standardizzati rispetto
allo spazio bioproduttivo medio mondiale (o “unità di superficie”,
come vengono dette nel LPR).
Criterio 4: Utilizzo di un modello disaggregato
per componenti o di uno aggregato
Mediante questo criterio si rileva se i risultati siano presentati suddivisi
in base ai componenti rilevanti per le politiche ambientali (edilizia, viaggi,
e così via) o meno.
Molti degli studi analizzati si collocano a metà fra le due tipologie
estreme di approccio in quanto scompongono il consumo in alcune soltanto delle
componenti individuate.
Criterio 5 Dati sui consumi: dati di origine
locale e dati di origine nazionale
Alcuni degli studi rilevano l’impossibilità o una grossa difficoltà
a reperire dati regionali, e dichiarano di aver dovuto ricorrere a dati nazionali
ponderati per la popolazione locale.
Ciò ha delle chiare conseguenze nella determinazione di impronte regionali
che presentino un certo grado di accuratezza. In una situazione ottimale I dati
disponibili dovrebbero essere stati raccolti esclusivamente per la regione oggetto
di studio, ma una approccio siffatto risulta difficile da standardizzare.
Criterio 6: Aggiunte rispetto al calcolo standard
dell’impronta
Mediante questo criterio si intende indicare se lo studio ha compiuto passi
ulteriori rispetto alla metodologia della IdN e se ha effettivamente cercato
di spiegare uno spettro più ampio di impatti.
Criterio 7: Omissioni rispetto al calcolo standard
dell’impronta
Questo criterio mostra se lo studio si è rivelato meno potente della
metodologia utilizzata per la IdN ed ha ricercato spiegazioni per un numero
minore di impatti o tipologie di terreno.
Criterio 8: Fonti
Suddivisione delle fonti rispetto all’origine: internazionale, nazionale
o dell’area geografica di interesse, ove questa sia contenuta all’interno
del territorio nazionale.
È preferibile far ricorso a fonti europee o internazionali, che potrebbero
in tal modo essere utilizzate per l’applicazione della metodologia dell’impronta
ecologica in diversi paesi per mezzo di un metodo di raccolta dati che presenti
caratteristiche di coerenza.
Criterio 9: Classificazione dell’energia
nucleare
Trattamento della controversa questione dell’energia nucleare.
La maggioranza degli studi attuali tratta l’energia nucleare in maniera
analoga ai combustibili fossili, per compensare i problemi relativi a calcoli
basati sul concetto di rischio.
Criterio 10: Stime dell’energia incorporata
utilizzate per il calcolo di manufatti/prodotti lavorati
Distinzione fra stime locali, nazionali o globali utilizzate per il calcolo
dell’energia contenuta in manufatti e prodotti lavorati.
Criterio 11: Contabilizzare il terreno edificato
Lo studio della IdN attribuisce al terreno edificato la medesima bioproduttività
della terra arabile. Alcuni altri studi attribuiscono invece al terreno edificato
una bioproduttività media.
Criterio 12: Contabilizzazione della biodiversità
La biodiversità viene spiegata in modi diversi: sia come sconto dall’offerta
(biocapacità disponibile) che come responsabilità per l’impronta
espressa in termini percentuali (LPR). In alcuni studi non si fa alcun riferimento
alla biodiversità.
Criterio 13: Assorbimento della CO2
In virtù della natura globale di questa sostanza inquinante, la maggioranza
degli studi fa uso del tasso di assorbimento medio globale riportato nella IdN.
Criterio 14: Considerazione della biocapacità
Questo criterio rileva se lo studio include un calcolo della biocapacità.
Ove infatti non si esegua tale calcolo, la valutazione della sostenibilità
della AGS risulta difficile da valutare.
Tavola 1: Confronto fra gli studi rispetto ai 14 criteri
| Studi (e AGS) | |||||||
| Criteri |
Italia (Torino) |
Olanda (vari) |
Svezia (vari) |
Finlandia (vari) |
Spagna (Navarra/Tudela) |
Norvegia (Stavanger) |
Regno Unito (vari) |
| 1: Principio Geografico o di Responsabilità |
Responsabilità |
Responsabilità? |
Responsabilità |
Responsabilità |
Responsabilità |
Responsabilità |
Responsabilità |
| 2: Uso di rendimenti locali o globali |
Si fa uso di rendimenti effettivi stimati (un misto fra locali, nazionali
e globali, a seconda dell’origine del bene considerato). |
I calcoli sono eseguiti sia rispetto ai rendimenti locali che a quelli globali. | Globali |
I calcoli vengono eseguiti sia rispetto a stime dei rendimenti effettivi
(un misto di rendimenti regionali, nazionali e globali, in base alla provenienza
del bene) che soltanto globali. La prima delle due forme sembra essere preferita.
|
Viene generalmente fatto uso dei rendimenti locali, tranne che nel caso
delle “importazioni”. |
Si fa uso dei rendimenti locali nel caso dei prodotti agricoli. |
I calcoli vengono eseguiti sia rispetto ai rendimenti locali che a quelli globali. |
| 3: Utilizzo dei fattori di equivalenza | Viene fatto uso dei fattori di equivalenza. | I fattori di equivalenza vengono introdotti solo nel caso dei rendimenti globali, preferiti ad altri. | Viene fatto uso dei fattori di equivalenza. | I fattori di equivalenza vengono introdotti solo nel caso dei rendimenti globali; questo non è però il metodo privilegiato. | ? | Viene fatto uso dei fattori di equivalenza. | |
| 4: Utilizzo di un modello disaggregato per componenti o di un modello aggregato | Modello disaggregato per componenti, con 5 componenti principali | Modello disaggregato per componenti, con 22 componenti principali | Aggregato | Modello disaggregato per componenti, con 5 componenti principali | Modello disaggregato per componenti, con 4 componenti principali | Modello disaggregato per componenti, con 5 componenti principali | Modello disaggregato per componenti, con 25 componenti principali |
| 5: Utilizzo di dati sul consumo locale . | Si è fatto uso di un mix di dati locali e nazionali corretti. | Prevalentemente di natura locale – eccezion fatta per i dati sull’energia?
Basato sulla ripartizione per gruppi di reddito |
. Si è fatto uso esclusivamente di dati sul consumo nazionale. | Beni alimentari, finiti e trasporto (meno il traffico su strada) sono nazionali. Il resto è locale | Ove disponibili, si è fatto uso di dati sul consumo locale | Per i beni alimentari e finiti, si è fatto uso di dati nazionali. Per edilizia, servizi e trasporto si è invece ricorso ad un mix di dati locali e nazionali. |
Tutti dati locali, esclusi i viaggi aerei (stimati per una regione più ampia) |
| 6: Aggiunte rispetto al calcolo standard dell’impronta ecologica | Si include il metano proveniente sia da discariche che da varie altre categorie di prodotti di consumo. Viene inoltre inclusa l’energia incorporata per prodotti alimentari e derivati dal legno. | Al fine di determinare il consumo si fa uso di dati desunti da LCA – e non di dati sugli scambi. Sono pertanto inclusi effetti ulteriori connessi al ciclo di vita? | Si osserva anche, in parte, l’inquinamento da N e P proveniente dall’agricoltura . | Approfondisce le questioni connesse ai derivati del legno in maniera più approfondita | No | No? | Al fine di determinare il consumo si fa uso di dati desunti da LCA – e non di dati sugli scambi. Sono pertanto inclusi effetti ulteriori connessi al ciclo di vita |
| 7: Omissioni rispetto al calcolo standard dell’impronta ecologica | Nessuna | Vengono escluse le aree marine? | Nessuna | Aree marine escluse | Vengono escluse le aree marine? | Nessuna | |
| 8: Fonti dei dati sui consumi | Piano Regolatore per il Territorio, ISTAT, Ministero Italiano dell’Industria e del Commercio, Annuario Statistico delle Nazioni Unite, Ambiente Italia, Osservatorio Provinciale sui Rifiuti | Ufficio Centrale Olandese di Statistica, RIVM, Sondaggio? | FAO | Fonti Finlandesi varie. | Istituto di Statistica della Navarra, DG per l’Agricoltura, l’allevamento e le risorse alimentari, dell’Industria e Lavoro, Dipartimento dei Lavori Pubblici, Trasporto e Comunicazioni. Ufficio per la Ricchezza del Territorio, Società di Fornitura di Energia, Consiglio Comunale di Tudela, Istituto Statistico Nazionale. ? | Oltre 200 organizzazioni locali, inclusi attività al dettaglio, fornitori di energia, compagnie di trasporto passeggeri e postali, scuole, Amministrazione Locale, impresa di smaltimento rifiuti, Agenzia Ambientale ecc. | |
| 9: Classificazione dell’energia nucleare | Classificata come combustibile fossile | Classificata come combustibile fossile | Classificata come combustibile fossile | Viene attribuita un’impronta molto bassa, del valore di 0.00002 ha - annui per GJ | Classificata come combustibile fossile? | ? | Classificata come combustibile fossile |
| 10: Stime dell’energia incorporata utilizzate per il calcolo dei prodotti manufatti/processati | Mix di valori relativi all’energia incorporata sia di livello nazionale che globale | ? | Globali (Hofstetter 1992) | Uso di valori globali (da Hofstetter 1992?) corretti per riflettere una minore percentuale di combustibili fossili nei beni importati, esclusi i prodotti derivati dalle foreste, per i quali vengono impiegati valori di intensità energetica di livello nazionale | Globali (Hofstetter 1992) | ? | Lo studio si basa su dati energetici desunti da vari studi sul ciclo di vita (incl. Hofstetter 1992). |
| 11: Contabilizzazione del terreno edificato | Considerata come terra arabile – corretta per un fattore di equivalenza? | Valutata come terra arabile | Valutata come terra arabile | Non corretta per fattori di equivalenza | Non viene applicato alcun fattore di equivalenza. | ? | Viene utilizzato il fattore di rendimento della. |
| 12: Contabilizzazione della Biodiversità | 12% dedotto dalla biocapacità | Non inclusa? | 12% dedotto dalla biocapacità | Si fa riferimento al 12%, che però non viene utilizzato. | Non inclusa | Non inclusa? | 12% dedotto dalla biocapacià |
| 13: Assorbimento della CO2 | Come nel FoN | Come nel FoN? | Come nel FoN | Si fa uso del valore di assorbimento locale | Si fa uso del valore di assorbimento locale | ? | Uses FoN figure for CO2 sequestration |
| 14: Considerazione della biocapacità | No? | Si | Si | Si | No? | Si? | Si |
| Ulteriori Commenti | Calcoli complessi. | Le relazioni metodologiche fondamentali sono disponibili solo
in Olandese. I calcoli più importanti sono confidenziali. L’approccio sembra comunque simile a quello inglese. |
Studio che più strettamente si attiene alla metodologia del FoN. | Vengono sviluppati 2 diversi scenari di consumo. | Disponibilità del solo sommario dello studio. | Accanto alla contabilizzazione nazionale proposta dal FoN,
si è sviluppato un approccio di tipo induttivo. Lo studio descrive vari scenari. |
|
Prospetto dei temi principali
Dall’esame degli studi europei sull’impronta ecologica sono
emersi alcuni punti fondamentali:
Il modello disaggregato per componenti ed il modello aggregato
Esiste una certa confusione sui due metodi di calcolo dell’impronta ecologica
(cfr. Simmons et al 2000; Ecological Economics, 32, 375-380; e Chambers et al
2000 per ulteriori informazioni su entrambi gli approcci).
La differenza principale è costituita dalle fonti cui ciascun metodo
fa ricorso per la stima della biocapacità assorbita. Il modello aggregato
stima i consumi in base a statistiche sugli scambi e bilanci energetici di livello
nazionale (facendo uso di un approccio di tipo deduttivo) ed è la metodologia
applicata negli studi della IdN/LPR. Il modello disaggregato determina il consumo
mediante l’analisi dei flussi di materiale e dei componenti le attività
(adottando quindi un approccio di tipo induttivo). Questo approccio metodologico
è stato dapprima sviluppato nel Regno Unito da Best Foot Forward ed un
approccio simile è stato adottato in Olanda. Le fonti principali cui
ricorre il modello disaggregato sono i sondaggi locali e le analisi del ciclo
di vita, pertanto la qualità dell’analisi dipende dalla possibilità
di accedere ad un database ambientale significativo.
Per altri versi, i due metodi sono invece simili. Ad esempio, entrambi riportano
i risultati in termini di “unità di superficie” medie mondiali.
Il modello aggregato, di tipo deduttivo, è stato adottato nello studio svedese, che ha fatto uso di statistiche relative al settore commerciale. Al fine di individuare eventuali notevoli differenze a livello locale/regionale, si erano utilizzate statistiche nazionali applicate alle attività regionali. Poiché lo standard e lo stile di vita non differiscono granché fra le varie aree del paese, non vennero riscontrate differenze rilevanti e l’impronta della AGS venne determinata moltiplicando l’impronta nazionale media per la popolazione della AGS. Le conclusioni che possono trarsi per la Svezia sono pertanto che è più probabile che le differenze nell’impronta degli individui siano determinate da differenze nel livello di reddito che dal luogo di residenza; conclusione che altrove potrebbe rivelarsi falsa.
Il modello disaggregato viene illustrato sia nello studio sull’Isola britannica di Wight che in quello sul Guernsey (il primo è disponibile sul sito www.bestfootforward.com; il secondo si trova in Ecological Economics 32, 375-380). Il primo si basava in misura significativa sulla banca dati dell’EcoIndex™, contenente dati sul ciclo di vita di prodotti e materiali e per realizzarlo è stato necessario contattare più di 200 organizzazioni. BFF ha altresì affiancato un attento studio sull’isola di Guernsey, oggetto della tesi di dottorato di John Barret (ora presso l’Istituto Ambientale di Stoccolma). Questi studi hanno evidenziato le differenze fra aree geografiche all’interno del Regno Unito. Tale risultato si spiega alla luce del fatto che il Regno Unito ha una popolazione più ampia e meno omogenea rispetto a paesi come la Svezia. Il vantaggio dell’approccio di tipo induttivo è da rintracciarsi nel fatto che esso è più educativo e che può essere facilmente applicato alle organizzazioni ed ai singoli prodotti. Lo svantaggio è che le fonti sono più settoriali, relative alla regione/organizzazione/attività oggetto di studio e che, quindi, la raccolta dati richiede maggior tempo. Si dovrebbe inoltre far attenzione a non conteggiare gli impatti due volte.
Il metodo utilizzato da Wackernagel et al (1998) per lo studio su Santiago
de Chile e successivamente da Redefining Progress e BFF per lo sviluppo dei
loro calcolatori di impronte on-line (si vedano: www.rprogress.org
e www.ecologicalfootprint.com)
combina elementi di entrambi gli approcci. Viene operata una disaggregazione
del consumo in componenti che rappresentano parti fondamentali dell’impronta
che sono calibrati per riflettere il 100% del consumo medio pro capite. Ove
quindi vengono usati dati nazionali medi pro capite, i risultati coincidono
con quelli riportati nel relativo studio della IdN/LPR. Le componenti utilizzate
nel caso di Santiago sono differenti da quelle utilizzate nei calcolatori –
mentre le regole di calcolo dell’impronta non cambiano.
Tavola 2: Componebti utilizzate per Santiago ed i calcolatori
| Santiago de Chile |
Calcolatore RP (12 domande) |
Calcolatore BFF (11 domande) |
| Cibo - vegetariano - prodotti animali - acqua |
Cibo - tipologia di dieta - quantità - rifiuti alimentari -“chilometraggio” del cibo |
Cibo - tipologia di dieta -“chilometraggio” e freschezza del cibo |
| Edilizia & arredamento |
Edilizia - numero di persone - dimensioni dell’abitazione - fonti di energia elettrica - efficienza energetica |
Edilizia - numero di persone - dimensioni dell’abitazione - bollette di riscaldamento/raffreddamento - fonti di energia elettrica - efficienza energetica |
| Trasporto - gommato - su rotaia - aereo - costale/fluviale |
Trasporto - chilometraggio dell’automobile - condivisione dell’auto - efficienza nell’uso dei combustibili - viaggi aerei |
Trasporto - modo di trasporto principale - distanza dei luoghi di villeggiatura e modo di trasporto |
| Beni - carta - abiti non sintetici - tabacco - altro |
Rifiuti - volume dei rifiuti - abitudini in ambito di riciclaggio (Nota: i rifiuti sono utilizzati come una variabile proxy per i prodotti lavorati) |
Le nostre raccomandazioni iniziali
Quanto segue rappresenta il punto di vista degli autori alla luce dei risultati di questo studio e della loro esperienza in ambito di applicazione e sviluppo dell’impronta ecologica e delle analisi sulla biocapacità e riflette il loro originario punto di vista circa il modo migliore di affinare l’uso della metodologia per indicare la sostenibilità delle AGS europee.
Raccomandazione 1. Si dovrebbe sviluppare un metodo generale per misurare l’impronta ecologica e la biocapacità da applicare in tutta Europa, indipendentemente dalle dimensioni e dalla popolazione della AGS. Tale metodo dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche:
Raccomandazione 2. Due sono le ragioni che
giustificano delle modifiche al metodo di calcolo dell’IdN/LPR: in primo
luogo, il desiderio di includere le idee rinvenute in altri studi dell’impronta
ecologica e, in secondo luogo, la necessità di semplificare i calcoli
dell’impronta per le AGS. Segue un elenco delle modifiche:
E’ opinione degli autori che le modalità di calcolo dell’energia nucleare restino invariate (essa viene considerata come combustibile fossile). Gli autori tuttavia riconoscono la necessità di sviluppare delle ulteriori ricerche che indaghino sull’attuale perdita di bioproduttività dovuta ai precedenti incidenti nucleari, sull’energia reale incorporata proveniente da combustibili fossili associata al ciclo di vita di un’installazione nucleare e sulla questione rischio applicata ai calcoli dell’impronta ecologica.
Raccomandazione 3. Per applicare la metodologia
dell’IdN/LPR alle AGS, sarà necessario utilizzare un criterio di
carattere settoriale o basato sulle attività. L’impronta media nazionale
dovrà pertanto essere disaggregata in componenti che possono essere compresi,
e quindi corretti, al livello di una AGS. A tal proposito, un buon esempio è
costituito dallo studio su Santiago de Chile, che può essere oggetto
di ulteriori elaborazioni. (si veda la precedente Tavola 2); approccio analogo
è stato adottato dallo studio svedese sulle aree sub – nazionali,
anche se la disaggregazione si è poi rivelata superflua per via della
scarsa significatività delle differenze fra le diverse aree.
Non è tuttavia ancora emersa alcuna metodologia standard per determinare
le impronte delle AGS in base a calcoli precedentemente effettuati a livello
nazionale, ma numerosi (Scozia, Galles e Londra nel solo Regno Unito) sono i
progetti impegnati nella definizione di un approccio standard fondato sull’aggiustamento
dei valori nazionali indicati dall’IdN/LPR. Si consiglia di correggere
i dati sul consumo rispetto alla media nazionale, utilizzando le differenze
relative fra le statistiche sul consumo a livello nazionale ed a livello della
AGS (che vengono anche detti: “fattori di correzione del consumo nelle
AGS”).
Ad esempio, nonostante la Scozia presenti l’8.6% della popolazione del
Regno Unito, le statistiche mostrano che gli Scozzesi consumano il 12% dell’energia
del Regno Unito. Quindi, in sede di determinazione dell’impronta ecologica
della Scozia (una AGS a sé) si dovrebbe considerare il 12% dell’impronta
energetica del Regno Unito. In tal modo, i dati dei servizi statistici nazionali
possono (ancora) essere utilizzati, ove esistenti, per cambiare il profilo di
consumo che emerge dall’insieme di dati dell’IdN/LPR, al fine di renderlo
coerente con quello della AGS.
È chiaro che un approccio siffatto richiede la raccolta di dati statistici
ed una loro coerente aggregazione a livello sia nazionale che delle AGS, in
modo che le differenze relative possano essere applicate ai risultati nazionali
sull’impronta contenuti nei fogli di calcolo dell’IdN/LPR.
Per affrontare il primo problema, si potrebbe introdurre un sondaggio (preferibilmente
mediante questionari sia cartacei che on – line) basato sia sulle esperienze
del Regno Unito che su quelle dell’Olanda e degli Stati Uniti, che può
essere utilizzato per stimare il consumo direttamente o indirettamente in aree
chiave in termini di stile di vita.
Questi cambiamenti sono necessari per trasformare le componenti dei calcoli
IdN/LPR in componenti più facilmente utilizzabili che possono poi essere
applicate post hoc ad ogni paese senza incidere sui dati grezzi esistenti. Ricorrendo
per esempio ai dati Eurostat, si riuscirebbe a determinare quanta parte della
componente di combustibile fossile liquido contenuta nei calcoli del consumo
energetico dell’IdN/LPR può essere attribuita ai diversi modi di
trasporto.
È chiaro che è necessario approfondire gli studi per definire
le relazioni fra i risultati sul consumo nazionale dell’IdN/LPR e le fonti
europee disponibili, oltre ai dati statistici necessari per collegare le due
cose.
Sarebbe auspicabile che i calcoli non divenissero eccessivamente laboriosi,
e che venissero automatizzati mediante la realizzazione di un modello di foglio
di calcolo. Lo sviluppo di tale modello è consigliato anche in vista
delle sue implicazioni in termini di aumento dell’accessibilità
delle informazioni ad un pubblico di profani e di garanzia di una maggior coerenza
ed integrità del metodo.
Raccomandazione 4. Come dimostrato dalle esperienze di molti paesi, l’impronta è uno strumento molto potente per il coinvolgimento dell’opinione pubblica, per cui qualunque sua applicazione dovrebbe essere realizzata in modo tale da ottenere il maggior vantaggio possibile da questa sua caratteristica.
Raccomandazione 5. Se utilizzato in modo appropriato,
il calcolo dell’impronta può anche dimostrarsi utile in sede di
definizione ed attuazione delle politiche. Sarebbe pertanto opportuno realizzare
un documento che illustri chiaramente i potenziali impieghi dell’EF/BC
in quest’ambito.
Domande & Risposte (Workshop di Oslo, Agosto
2001)
La prima versione di questa relazione (datata 3 Agosto) è stata presentata
ai partecipanti al workshop di Oslo Workshop sull’Impronta Ecologica, tenutosi
dal 24 al 26 Agosto 2001 .(2)
Di seguito si riportano i quattro argomenti evidenziati dalla relazione originaria
come punti da discutere in dettaglio durante il workshop, insieme ai relativi
accordi raggiunti nel corso dei lavori.
D1: Cosa si vuole misurare: l’attività
economica all’interno di un’area geografica (principio geografico)
o il consumo attribuibile ai residenti di quell’area, sia che l’impatto
si verifichi al di fuori che all’interno della AGS stessa (principio di
responsabilità)?
Conclusioni raggiunte nel corso del workshop:
Nonostante la terminologia in questione sia già utilizzata all’interno
del Progetto sugli Indicatori Europei, essa ha causato una certa confusione
ed è stata oggetto di discussione.
Le conclusioni in merito sono che la AGS desidererebbe misurare l’impatto
ambientale di tutte le attività all’interno dei propri confini (secondo
il principio geografico) ma che ad essere riportata per gli Indicatori Europei
sia solo quella parte di consumo attribuibile ai residenti all’interno
dell’area stessa (secondo il principio di responsabilità) per garantire
la comparabilità fra le diverse regioni. Il Progetto ECI dovrebbe comunque
offrire assistenza alle singole aree nel calcolo dell’indicatore secondo
il principio geografico e, idealmente, qualunque strumento o istruzione di calcolo
realizzato dovrebbe coprire questo aspetto della misura dell’impronta.
Durante la discussione alcuni dei partecipanti hanno mostrato diagrammi utili
a chiarire quale parte dell’impronta di una AGS dovrebbero essere riportati
a fini ECIP. Il diagramma che segue (Diagramma 1) illustra tutti gli impatti
che potrebbero registrarsi all’interno di una AGS rappresentativa che presenti
una fabbrica di alluminio, un aeroporto ed un settore turistico significativo.
Diagramma 1: Porzione dell’impronta di una AGS che verrebbe riportata a fini ECIP: ad essere riportata sarebbe la sola fetta nera del diagramma a torta.
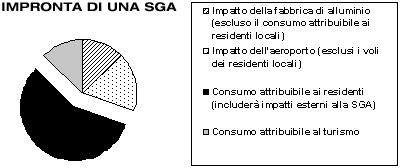
D2: E’ opportuno confrontare l’impronta
con la biocapacità della AGS stessa, con quella mondiale, con quella
europea o con ciascuna di tali grandezze?
Conclusioni del workshop:
Si consiglia di confrontare l’impronta delle AGS soprattutto con la biocapacità
mondiale, anche se si ritiene opportuno che anche la biocapacità nazionale
venga resa nota. Il confronto con la biocapacità locale è stato
invece sconsigliato, poiché è irrealistico pensare che una grossa
città si approvvigioni a livello locale. Dovrebbero essere considerate
anche questioni etiche: dove potrebbero dirigersi le persone che risiedono in
aree sovrappopolate? Inoltre, individui che vivono in aree con un surplus di
biocapacità, potrebbero sentirsi tranquilli e pensare di poter continuare
a mantenere lo stile di vita precedente.
Tutto ciò deve comunque valutarsi in relazione alla valenza informativa
ed educativa insita nell’osservazione della biocapacità locale,
che riveste un’importanza fondamentale nell’ambito di un discorso
di pianificazione sostenibile da parte della comunità; quanto sopra deve
anche esser valutato in relazione all’allocazione della biocapacità,
trasferita dalla AGS alla nazione, all’UE ed all’intero pianeta per
la preservazione della biodiversità; elemento chiave a tal fine è
la riduzione della biocapacità utilizzata per l’agricoltura e la
forestazione per mantenere la biodiversità ed i servizi ecologici.
In sostanza, si è raggiunto un consenso circa il fatto che qualunque
(strumento o) linea guida si definisca, essa dovrebbe illustrare alle AGS le
modalità di calcolo della propria biocapacità, ma che quest’ultima
non dovrebbe far parte del rapporto a fini ECIP.
D3: Può la metodologia contenuta nell’IdN/LPR
costituire la base dei calcoli dell’EF/BC delle AGS? (ossia uso dell’impronta
nazionale principale con aggiustamenti per le AGS e di misurazioni della BC
locale da parte della AGS).
Conclusioni del workshop:
Il metodo IdN/LPR è stato generalmente approvato; si ipotizza comunque
di apportarvi alcuni cambiamenti e miglioramenti (come già illustrato
sopra e nella D4 più sotto).
Tutti i presenti concordavano sul fatto che i cambiamenti venissero apportati
di concerto con gli autori dell’IdN/LPR.
D4: Quali sono i cambiamenti da apportare
alla metodologia del IdN/LPR – sia per migliorare la contabilizzazione
che per renderla applicabile alle AGS? I punti comprendono quelli evidenziati
nel confronto fra gli studi d’area europei considerati in questo lavoro,
come ad esempio il modo di gestire i seguenti elementi:
-energia incorporata nei prodotti/beni scambiati
-energia nucleare
-biodiversità
-terreni edificati
Nel corso delle loro discussioni, gli autori hanno rilevato in prima persona
gli evidenti divari esistenti fra paesi europei in termini di poteri amministrativi
e distribuzione delle responsabilità a livello sub – nazionale.
Tali differenze hanno delle notevoli ricadute sulla quantità e qualità
dei dati a disposizione delle AGS, nonché sulla possibilità di
incidere sui processi decisionali. Al fine di consentire ai partner di comprendere
la situazione di altre aree d’Europa in maniera più approfondita,
sarebbe opportuno che ciascun partecipante all’incontro di Oslo delineasse
brevemente il quadro della situazione nella propria area di provenienza.
Conclusioni del workshop:
Nonostante si sia manifestato un consenso generale intorno alle iniziali proposte
degli autori, si è ritenuto preferibile che la discussione di queste
ed altre questioni metodologiche venisse riservata ad un incontro di esperti
più ristretto che includesse le entità coinvolte negli studi pilota
progettati. L’incontro dovrebbe auspicabilmente tenersi al più presto
(Settembre/Ottobre 2001).
Si è inoltre espressa preoccupazione circa il fatto che il suddetto gruppo
di esperti non sarà finanziato in maniera indipendente, ma che dovrebbe
appoggiarsi a contributi provenienti dal progetto pilota.
In maniera analoga, non sono al momento disponibili risorse per i contatti con
gli autori degli studi IdN/LPR, con i quali (probabilmente Mathis Wackernagel
e Jonathon Loh) sarebbe opportuno raggiungere un accordo entro la fine dell’anno,
per permettere che gli eventuali cambiamenti vengano inseriti nel prossimo IdN/LPR.
Ulteriori Commenti/Decisioni emerse nel corso del Workshop.
Differenze nei poteri amministrativi
e responsabilità fra AGS diverse
Nella versione iniziale di questo rapporto gli autori hanno sottolineato la
necessità di discutere le differenze in termini di poteri amministrativi
e responsabilità da Paese a Paese, che incidono notevolmente su quantità
e qualità dei dati disponibili per le AGS nonché sulle possibilità
di influenzare i processi decisionali. Si è convenuto che, al fine di
consentire a tutti i partner di comprendere la situazione in altre parti d’Europa,
i presenti all’incontro di Oslo illustrassero la situazione dei propri
luoghi di provenienza. La discussione dell’argomento non è risultata
molto ampia, nonostante si sia manifestato un certo consenso intorno all’argomento
stesso.
Problemi inerenti l’ottenimento
dei dati sull’energia
Nel corso dell’incontro tenutosi a Roma, tutti i partner hanno
evidenziato difficoltà ad ottenere i dati energetici, in parte a causa
del processo di liberalizzazione del mercato energetico. I partner hanno espresso
il desiderio di vedere che provvedimenti in merito vengano presi a livello europeo.
Di questo argomento si è nuovamente discusso nel corso del workshop di
Oslo.
Reazione alla Raccomandazione
1 contenuta nel rapporto iniziale
La raccomandazione 1 sottolineava la necessità di sviluppare un metodo
generale per il calcolo dell’impronta ecologica e della biocapacità
applicabile in tutta l’UE, indipendentemente dalle dimensioni della AGS
e della sua popolazione. Si consiglia che il metodo presenti alcune caratteristiche
di cui si è discusso ad Oslo in relazione ai punti 1, 2, e 3.
Come sopra riportato, le raccomandazioni dell’autore sono state accettate.
Reazione alla Raccomandazione
2 contenuta nel rapporto iniziale
La raccomandazione 2 affrontava la questione dei cambiamenti da apportare alla
metodologia IdN/LPR.
Come già osservato, un accordo su queste questioni è stato raggiunto,
ma le decisioni finali sono state affidate ad un incontro di esperti.
Reazione alla Raccomandazione
3 contenuta nel rapporto iniziale
La raccomandazione 3 descriveva la metodologia ritenuta preferibile più
nel dettaglio. Anche in questo caso si è convenuto che la decisione fosse
affidata al gruppo di esperti, a fronte di un generale accordo comunque raggiunto
nel corso del workshop di Oslo, il che costituisce una buona base per queste
discussioni. Esse sono riportate di seguito nella sezione intitolata “discussioni
di Oslo sulla Metodologia”.
Reazione alla Raccomandazione
4 contenuta nel rapporto iniziale
La Raccomandazione 4 recitava:
Come dimostrato dalle esperienze di più paesi, l’impronta ecologica
è uno strumento molto potente per il coinvolgimento dell’opinione
pubblica. Ogni suo utilizzo dovrebbe essere promosso in modo da ottenere il
massimo da questa sua caratteristica.
Questa osservazione è stata generalmente accettata.
I partecipanti sono rimasti colpiti dalla coerenza della campagna educativa
rivolta al pubblico portata avanti in Olanda ed hanno espresso il desiderio
di vedere la realizzazione di un’iniziativa simile anche a livello Europeo.
Si è pensato di inserire un questionario sullo stile del “quick
scan” da mettere sul web, che non solo avrebbe stimato l’impronta
ecologica individuale, ma avrebbe anche svolto il ruolo di strumento per la
raccolta dati del tipo richiesto dagli autori stessi.
Craig Simmons si è impegnato a ricercare fondi per questa iniziativa
insieme ad Anthony van de Ven.
Reazione alla Raccomandazione
5 contenuta nel rapporto iniziale
La Raccomandazione 5 recitava:
Se utilizzata in maniera adeguata, l’impronta ecologica potrebbe anche
rivelarsi di aiuto per le scelte politiche. Sarebbe opportuno realizzare un
documento che offra delle indicazioni precise circa i possibili usi dell’EF/BC
in questo contesto.
Su questo punto si è raggiunto un generale consenso.
Nonostante non esistano ancora dei fondi disponibili per finanziare la produzione
di un documento di questo genere, essi potrebbero essere reperiti insieme a
quelli destinati all’iniziativa di cui al punto precedente.
Oslo – Discussioni Metodologiche
Anche se nel corso del workshop si era giunti alla conclusione che le decisioni
finali in materia di metodologia dovrebbero essere affidate ad un gruppo più
ristretto di esperti, anche nel corso del workshop si sono fatti dei passi avanti
in ambito metodologico. I punti su cui si è effettivamente raggiunto
un consenso generale sono illustrati di seguito (si veda anche il diagramma
2).
Fonti
Come già osservato, i calcoli dovrebbero basarsi su analisi degli
scambi internazionali e su calcoli di biocapacità, come illustrato nello
studio dell’IdN e secondo il procedimento seguito dal LPR. I relativi fogli
di calcolo sono disponibili in rete sul sito di Redefining Progress (www.rprogress.org)
e dovrebbero essere regolarmente aggiornati dal WWF International. Il prossimo
aggiornamento è in corso di realizzazione e dovrebbe essere pronto per
l’Autunno 2002.
In tal modo, ciascuno dei paesi partecipanti può ottenere il proprio
foglio di calcolo che mostra il consumo totale per circa 120 voci suddivise
in 7 categorie (prodotti alimentari di derivazione animale, prodotti non alimentari
di derivazione animale, prodotti alimentari vegetali, prodotti chimici, ecc.).
Il foglio di calcolo conterrà anche la spesa allocata per il settore
energetico nonché la biocapacità del paese di riferimento. L’impronta
di ciascun elemento consumato, inclusa la terra utilizzata per ottenere energia
secondo quanto nel bilancio energetico, viene espressa mediante un misura di
superficie (ettari di spazio produttivo medio mondiale) I risultati sono aggregati
in un’impronta ecologica media nazionale.
Sarà necessario identificare fonti di dati di livello europeo, che consentano
una riorganizzazione degli elementi contenuti nei fogli di calcolo nazionali
in gruppi definiti in base a settori/attività, che siano più direttamente
connessi alle attività ed agli acquisti dei consumatori. Il fatto che
le fonti siano di livello europeo dovrebbe garantire l’esistenza di una
metodologia comune. (A tal proposito, sarebbe auspicabile che esistesse un data
shop dell’Eurostat in ogni paese).
In un secondo momento sondaggi nazionali e locali, insieme ad altre ricerche
di carattere locale permetteranno la quantificazione del divario fra consumo
della AGS e media nazionale (come illustrato nella raccomandazione iniziale
numero 3).
Anche se, allo scopo di adottare effettivamente un approccio comune, nei rapporti
a fini ECIP si deve far uso dei rendimenti globali, qualunque paese/AGS lo desideri
può ricalcolare i propri risultati in termini di rendimenti locali.
Diagramma 2: Primi spunti sulle modalità di
integrazione fra statistiche nazionali e locali.
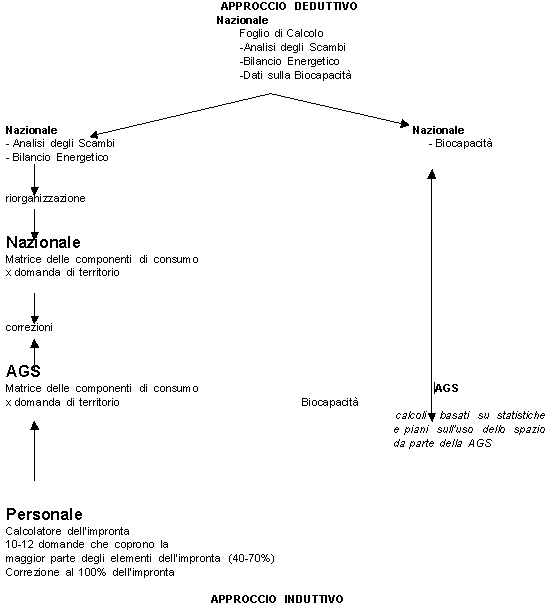
Gruppi tematici sui Componenti
del Consumo
Al fine di mantenere una certa semplicità metodologica e reportistica,
si è deciso che fosse sufficiente richiedere che l’indicatore ECIP
considerasse solo cinque delle voci che costituiscono l’impronta.
Molte, se non addirittura la più parte, delle AGS vorrebbero calcolare
un numero molto maggiore di componenti dell’impronta – sia all’interno
del procedimento complessivo di calcoli che, anche, come supporto all’attuazione
delle politiche ed allo sviluppo di scenari. Queste componenti “addizionali”
dovrebbero essere organizzate in una gerarchia collegata alle cinque componenti
principali.
Potrebbe anche accadere che, nel caso delle componenti di minor rilievo, una
AGS non desideri utilizzare l’analisi dell’impronta ecologica; in
termini di reporting, vi è flessibilità anche in questo senso.
Ad esempio, ove si rinvenisse un’impronta del settore edile particolarmente
grossa, la AGS potrebbe liberamente ricorrere ad una tecnica come quella dell’Indicatore
di Sostenibilità di Processo (SPI) per esplorare più a fondo i
motivi di un tale risultato ed eventualmente scegliere tecnologie meno impegnative.
È inoltre importante notare che l’introduzione di questa gerarchia
fra i componenti consente anche un maggior ricorso a fonti di natura locale
per indagare su impatti minori, ove fonti/statistiche di livello europeo offrirebbero
un livello di accuratezza insufficiente.
Le 5 componenti principali consigliate sono illustrate
nella tabella 3 di seguito.
N.B.: In seguito al workshop si è rilevato che il data shop Svedese dell’Eurostat
è in grado, a pagamento, di riorganizzare i dati sui consumi di carattere
commerciale in gruppi di componenti del consumo. Si consiglia di realizzare
uno studio pilota su questo argomento.
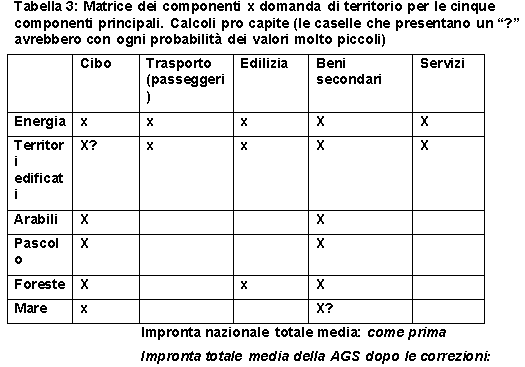
Metodo di Calcolo
La matrice della Tabella 3 viene dapprima realizzata per il cittadino
nazionale medio e successivamente corretta per rispecchiare le caratteristiche
della AGS, considerando la differenza fra consumo locale e nazionale. In tal
modo si riesce a calcolare un valore relativo al residente medio della AGS.
Da un punto di vista metodologico, al fine di garantire compatibilità
di approcci in tutta Europa, sono necessarie ulteriori ricerche ed informazioni.
La stima della biocapacità di una AGS sarà molto accurata rispetto
a stime relative ad altre aree geografiche, in quanto per essa dovrebbe essere
più agevole reperire informazioni sull’uso del territorio nel settore
agricolo, sulle aree edificate, sulle aree destinate a strade, depositi ed altre
installazioni per la protezione delle acque, per riserve naturali, ecc. Le informazioni
sull’intensità della gestione e sulla rendita di tali aree può
reperirsi soltanto a livello locale, come anche accade per i dati sulla quantità
di biocapacità preservata a vantaggio della preservazione dell’ecosistema
e della biodiversità. Gli scostamenti dalla capacità media nazionale
pro capite potrebbero quindi rivelarsi considerevoli, e di essi si potrebbe
tenere conto ai fini del processo di pianificazione.
Uso dei Sondaggi
Uno strumento di indagine come il Quick Scan olandese o l’EcoCal
inglese (entrambi disponibili sia in forma di questionari cartacei che elettronici)
possono essere utilizzati sia per coinvolgere il pubblico che per raccogliere
dati specifici relativi alle AGS. I risultati possono essere utilizzati per
correggere l’impronta nazionale media o per validare altre fonti di dati.
Lo sviluppo di uno strumento di indagine che si inserisca in un approccio di
respiro europeo richiede ulteriori studi.
Foglio di Calcolo
Altro argomento centrale di discussione sono statigli strumenti per
il calcolo dell’impronta ecologica. È importante che le amministrazioni
siano in grado di eseguire i calcoli in maniera autonoma.
I presenti hanno approvato l’idea di sviluppare un programma/foglio di
calcolo che vada oltre i calcoli relativi alle componenti base che offra un’assistenza
ed una guida più ampie in materia di calcoli.
Preparato per Ambiente Italia (ECIP)
da Lillemor Lewan,
Centro Studi Ambientali, Università di Lund, Svezia
email: Lillemor.Lewan@miclu.lu.se
Craig Simmons, Best Foot Forward, The Future Centre, Oxford, United Kingdom
email: craig@bestfootforward.com